di BARBARA SPINELLI
NEL PRESENTARE il proprio governo, il 16 novembre scorso, il nuovo premier Mario Monti ha raccontato come i dirigenti dei partiti abbiano preferito non entrare nell'esecutivo e ha aggiunto un'osservazione significativa, e perturbante. "Sono arrivato alla conclusione, nel corso delle consultazioni, che la non presenza di personalità politiche nel governo agevolerà, piuttosto che ostacolare, un solido radicamento del governo nel Parlamento e nelle forze politiche, perché toglierà un motivo di imbarazzo".
La frase turba perché con un certo candore rivela una verità oculatamente nascosta. Così come sono congegnati, così come agiscono da decenni, i partiti non sanno fare quel che prescrive la Costituzione: non sono un associarsi libero di cittadini che "concorre con metodo democratico a determinare la politica nazionale"; rappresentano più se stessi che i cittadini; e nel mezzo della crisi sono motivo d'imbarazzo. Il nuovo premier ama la retorica minimalista - la litote, l'eufemismo - ma quando spiega che le forze politiche non vogliono scottarsi perché "stanno uscendo da una fase di dialettica molto molto vivace tra loro" (e non senza asprezza aggiunge: "Spero, che stiano uscendo") snida crudamente la realtà.
È una realtà che dovrebbe inquietarci, dunque svegliarci: al momento, i partiti sono incapaci di radicare in Parlamento e in se stessi l'arte del governare. Sanno conquistare il potere, più che
esercitarlo con una veduta lunga e soprattutto precisa del mondo. Sono come reclusi in un cerchio. È ingiusto che Monti deprezzi la nobile parola dialettica. Ma i partiti se lo meritano.
Questo significa che l'emergenza democratica in cui viviamo da quando s'è disfatto il vecchio sistema di partiti, nei primi anni '90, non finisce con Berlusconi: il berlusconismo continua, essendo qualcosa che è in noi, nato da storture mai raddrizzate perché tanti vi stanno comodi. Il berlusconismo irrompe quando la politica invece di ascoltare e incarnare i bisogni della società accudisce i propri affari, spesso bui. La dialettica, che dovrebbe essere ricerca dell'idea meno imprecisa, per forza degenera. È a quel punto che le lobby più potenti, constatando lo svanire di mediatori tra popolo e Stato, si mettono a governare direttamente, accentuando lo sradicamento evocato da Monti.
Questa volta, a differenza di quanto accadde nel '94, entrano in scena tecnici di grande perizia, e l'Età dei Torbidi con ministri inetti, eversivi, premiati perché asserviti al capo, è superata. Ma non tutto di quell'età è superato, e in particolare non il vizio maggiore: il conflitto d'interessi. Un vizio banalizzato, quando a governare non sono solo accademici e civil servants europei come Monti, ma banchieri che sino al giorno prima hanno protetto non la cosa pubblica bensì i profitti di aziende, banche. È il caso di Corrado Passera, che appena nominato ha lasciato Banca Intesa ma guida dicasteri e deleghe (sviluppo, infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni) legati rischiosamente ad attività di ieri. Sarà ardua la neutralità, quando si tratterà di favorire o no i treni degli amici Montezemolo e Della Valle, di favorire o no quell'Alitalia che lui stesso (con i sindacati) volle italiana, nel 2008, assecondando l'insania di Berlusconi e affossando l'accordo di Prodi e Padoa-Schioppa con Air France: l'italianità costò ai contribuenti 3-4 miliardi di euro, e molti disoccupati in più. Passera assicura: "I fatti dimostreranno" che conflitto d'interessi non c'è. Vedremo. Il male che Monti denunciò su La Stampa il 4-5-07 (il "potere occulto delle banche", la "confusione tra politica e affari") e tanto irritò Passera, per ora resta.
Alcuni dicono che la democrazia è sospesa, e qualcosa di vero c'è perché la Repubblica italiana non nacque come Repubblica di ottimati. Ma il grido di sdegno suona falso, e non solo perché la Costituzione non prevede l'elezione di un premier, caduto il quale si torna al voto. È falso perché preserva, occultandolo, uno dei nostri più grandi difetti: l'inattitudine a esplorare i propri storici fallimenti.
Se la democrazia viene affidata ai tecnici e alla loro neutralità ideologica, è perché politica e partiti hanno demandato responsabilità che erano loro, specie in tempi di crisi. Perché non hanno raccontato ai cittadini il mondo che muta, lo Stato nazione che ovunque vanta sovranità finte, l'Europa che sola ci permette di ritrovare sovranità. Perché non dicono che esiste ormai una res publica europea, con sue leggi, e che a essa urge lavorare, dandole un governo federale, un Parlamento più forte, una Banca Centrale vera. Non domani: oggi.
La situazione italiana ha una struttura tragica, che toccò l'acme quando fu scoperchiata Tangentopoli ma che è più antica. Ogni tragedia svela infatti una colpa originaria, per la quale son mancate espiazioni e che quindi tende a riprodursi, sempre più grave: non a caso non è mai un eroe singolo a macchiarsi di colpe ma un lignaggio (gli Atridi, per esempio). La colpa scardina la pòlis, semina flagelli che travolgono legalità e morale pubblica. Alla colpa segue la nemesi: tutta la pòlis la paga.
In Italia la scelleratezza comincia presto, dopo la Liberazione. Da allora siamo impigliati nel cortocircuito colpa-nemesi, senza produrre la catarsi: il momento della purificazione in cui - nelle Supplici di Eschilo - s'alza Pelasgo, capo di Argo, e dice: "Occorre un pensiero profondo che porti salvezza. Come un palombaro devo scendere giù nell'abisso, scrutando il fondo con occhio lucido e sobrio così che questa vicenda non rovini la città e per noi stessi si concluda felicemente". Lo sguardo del palombaro è la rivoluzione della decenza e della responsabilità che tocca ai partiti, e l'avvento di Monti mostra che l'anagrafe non c'entra. Sylos Labini che nel '94 vide i pericoli non era un ragazzo. Scrive Davide Susanetti, nel suo bel libro sulla tragedia greca, che il tuffo di Pelasgo implica una più netta visione dei diritti della realtà: "Per mutare non bisogna commuoversi, ma spostarsi fuori dall'incantesimo funesto del cerchio" che ci ingabbia (Catastrofi politiche, Carocci 2011).
Monti non è ancora la guarigione, visto che decontaminare spetta ai politici. Per ora, essi vogliono prendere voti come ieri: vendendo illusioni. Ma Monti è un possibile ponte tra nemesi e catarsi. Già il cambiamento di linguaggio conforta: sempre le catarsi cominciano medicando le parole. L'ironia del premier sull'espressione staccare la spina è stata un soffio di aria fresca nel tanfo che respiriamo. Altre parole purtroppo restano. Quando Passera dice che "sì, assolutamente" usciremo dalla crisi, usa il più fallace degli avverbi. Anche la parola blindare andrebbe bandita: nasce dal linguaggio militare tedesco (lo scopo è render l'avversario cieco, blind). Non è una bella dialettica.
Monti è l'occasione, il kairòs che se non cogliamo c'inabissa. Per i partiti, è l'occasione di mutare modi di pensare, rappresentare, in Italia e soprattutto in Europa. Di ricominciare la "lunga corsa" intrapresa dopo il '45. Di darsi un progetto, non più sostituito dall'Annuncio o l'Evento: quell'Evento, dice Giuseppe De Rita, "che scava la fossa in cui cadrà il giorno dopo".
Non c'è un solo partito che abbia idee sull'Europa da completare. Non ce n'è uno che dica il vero su clima, demografia, pensioni, disuguaglianza, crisi che riorganizza il mondo. Diciamo commissariamento, come se poteri europei fatali ci comandassero. In realtà siamo prede di forze lontane perché l'Europa politica non c'è. Monti denunciò a giugno l'eccessiva deferenza fra Stati dell'Unione. Speriamo non sia troppo deferente con Berlino. Che glielo ricordi: le austerità punitive imposte prima della solidarietà sovranazionale sono come le Riparazioni sfociate dopo il 14-18 nella fine della democrazia di Weimar.
Le patologie italiane permangono, nonostante i molti onest'uomini al governo. Il fatto che il partito più favorevole a Monti, l'Udc, sia invischiato nelle tangenti Enav-Finmeccanica, e si torni a parlare di "tritacarne mediatico", è nefasto. Il pensiero profondo che salva lo si acquisisce solo se si scende giù nell'abisso, scrutando il fondo. Scrutarlo con l'aiuto di un'informazione indipendente aiuterà chi pensa che non basti un Dio, per risollevarci e rimettere nei cardini il mondo.



 raccomandano
gli economisti facenti capo a Randall Wray e lo stesso Richard Werner,
autore di “New Paradigm in Macroeconomics”. «Sono letture utili», dice
Sardi, «un ottimo antidoto rispetto all’intossicazione di “pensiero
unico” che vi propineranno in questi mesi da ogni direzione,
approfittando della vostra soddisfazione per l’eclisse di Silvio
raccomandano
gli economisti facenti capo a Randall Wray e lo stesso Richard Werner,
autore di “New Paradigm in Macroeconomics”. «Sono letture utili», dice
Sardi, «un ottimo antidoto rispetto all’intossicazione di “pensiero
unico” che vi propineranno in questi mesi da ogni direzione,
approfittando della vostra soddisfazione per l’eclisse di Silvio  gruppo Bilderberg, santuario della
gruppo Bilderberg, santuario della  invece «siamo così ipnotizzati dall’andamento dei mercati da non accorgercene nemmeno».
invece «siamo così ipnotizzati dall’andamento dei mercati da non accorgercene nemmeno».
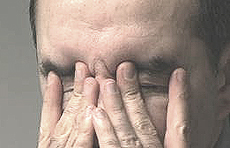 decise da tecnocrati pro-business non eletti», e siamo ridotti a non disporre più di alcuna sovranità finanziaria, «visto che non abbiamo più una nostra moneta sovrana, ma usiamo l’Euro che è una moneta straniera, dal momento in cui è emesso da entità non italiane e lo dobbiamo prendere in prestito». In altre parole, quello che ci tocca fare è «solo ubbidire e applicare le politiche volute da altri». Ma attenzione, avverte Barnard: la lettera che il governo italiano ha consegnato a Bruxelles non è destinata all’Unione Europea, bensì ai veri padroni del mondo: vale a dire «gli investitori internazionali, quelli che oggi prestano ogni singolo Euro che lo Stato italiano spende per i cittadini».
decise da tecnocrati pro-business non eletti», e siamo ridotti a non disporre più di alcuna sovranità finanziaria, «visto che non abbiamo più una nostra moneta sovrana, ma usiamo l’Euro che è una moneta straniera, dal momento in cui è emesso da entità non italiane e lo dobbiamo prendere in prestito». In altre parole, quello che ci tocca fare è «solo ubbidire e applicare le politiche volute da altri». Ma attenzione, avverte Barnard: la lettera che il governo italiano ha consegnato a Bruxelles non è destinata all’Unione Europea, bensì ai veri padroni del mondo: vale a dire «gli investitori internazionali, quelli che oggi prestano ogni singolo Euro che lo Stato italiano spende per i cittadini». come dimostra la drammatica vertenza Italia-Bce.
come dimostra la drammatica vertenza Italia-Bce. capitoli-capestro, nel testo consegnato a Bruxelles? Purtroppo sì, risponde Barnard. Il piano procede, ed è contro di noi in ogni aspetto della spesa sociale: salari, pensioni, tasse, spesa pubblica, licenziamenti facili, lavoro ancora più precario.
capitoli-capestro, nel testo consegnato a Bruxelles? Purtroppo sì, risponde Barnard. Il piano procede, ed è contro di noi in ogni aspetto della spesa sociale: salari, pensioni, tasse, spesa pubblica, licenziamenti facili, lavoro ancora più precario.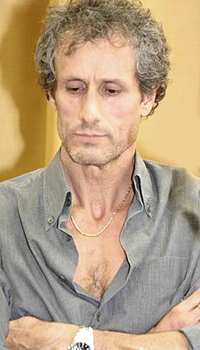 servizio senza aver prima verificato se era possibile aprire una gara fra soggetti privati», mentre le Regioni «dovranno stilare piani urgenti di privatizzazioni locali». E infine, la Costituzione: «Sarà riformata per introdurre articoli pro business. Le conseguenze sulle tutele costituzionali del bene pubblico sono imprevedibili (no, prevedibili: le distruggeranno)».
servizio senza aver prima verificato se era possibile aprire una gara fra soggetti privati», mentre le Regioni «dovranno stilare piani urgenti di privatizzazioni locali». E infine, la Costituzione: «Sarà riformata per introdurre articoli pro business. Le conseguenze sulle tutele costituzionali del bene pubblico sono imprevedibili (no, prevedibili: le distruggeranno)».